Tre libri che
parlano di giornali
—————-
di Beppe Colli
Oct. 29, 2020
E’ ormai assodato che
viviamo tempi davvero bizzarri, e basta uscire per strada e fare due passi
aprire la finestra e dare un’occhiata in giro per averne conferma.
Ma ogniqualvolta ci sorprendiamo a interrogarci su quale sia
stato il momento da noi percepito quale cesura, il pensiero torna sempre alla
campagna che ha preceduto il referendum sulla Brexit e al periodo
immediatamente successivo alla proclamazione dei risultati.
Il decennio non era stato certo parco di "momenti
storici" – ci vengono sempre in mente le dirompenti rivelazioni di
WikiLeaks, con Julian Assange nel ruolo di protagonista, e lo scandalo
concernente il sistema di sorveglianza di stampo orwelliano messo in opera
dalla statunitense NSA fatto esplodere da Edward Snowden – ma l’immane sforzo
propagandistico in cui si era prodotto il fronte favorevole all’uscita del
Regno Unito dalla Comunità Europea ci era parso avere pochi precedenti, con
l’ovvia eccezione dei ben noti episodi che avevano caratterizzato la
"Guerra Fredda".
E qui dobbiamo dire che molti degli argomenti messi in campo
dal "Leave" ci erano sembrati tanto fasulli e di così ardua
credibilità – avevamo seguito l’intera vicenda sul Guardian, ed era stato in
seguito all’eccellente lavoro giornalistico fatto da quel quotidiano che
avevamo messo per la prima volta mano al portafoglio – da farci sospettare un
rimbecillimento di massa.
Se non erano mancati episodi tragici – non dimentichiamo
l’uccisione della deputata laburista Jo Cox e quelle foto dei giudici sbattute
in prima pagina sotto la scritta "Enemies of the People" – l’immagine
che ci era rimasta impressa nella memoria era quella dell’autobus che aveva
girato il Paese durante la campagna referendaria e sulla cui fiancata compariva
la scritta "We send the EU £350 million a week, let’s fund our NHS
instead".
La cifra era palesemente gonfiata, la sua destinazione un
pio desiderio – il Partito Conservatore che aveva governato per tanto tempo il
Regno Unito aveva fatto carne di porco dello Stato Sociale, la Sanità in primo
luogo (non ci servivano i film di Ken Loach per saperlo: non pochi colleghi di
quei luoghi ci dicevano di mesi di attesa per una semplice radiografia alla
colonna).
Stante la credulità "selettiva" dell’elettore,
come aveva potuto uno slogan tanto palesemente falso – e che è stato in seguito
considerato arma decisiva per il successo del fronte "Leave" – godere
di legittima circolazione? Una storia giunta nelle aule di tribunale di lassù,
con Boris Johnson coinvolto nella vicenda.
(Chi è appassionato di storie legali può agevolmente
consultare in Rete, a oggi, l’articolo di Andrew Reid intitolato Buses and
Breaking Point: Freedom of Expression and the "Brexit" Campaign
apparso su Ethical Theory and Moral Practice volume 22, pages 623-637, 2019.)
In conclusione di punto, va sottolineato che una larga parte
della stampa di quei luoghi è stata complice dell’impresa e potente megafono di
quelle menzogne.
Pochi giorni fa
leggevamo dell’ennesima bugia detta dal Presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump, nel corso di un recente comizio: il numero dei morti per Covid in quel
Paese è largamente sovrastimato in ragione del fatto che medici e ospedali
ricevono una somma superiore se tra le cause della morte indicano
"Covid". Circostanza falsa e del tutto inventata. E una bugia che va
ad aggiungersi alle oltre 20.000 dette da Trump dal momento della sua elezione
secondo il conteggio effettuato dal quotidiano statunitense Washington Post.
Contare le bugie non è un lavoro semplice. E lo è ancor meno
se queste sono in numero enorme, con un Presidente che fin dal primo giorno di
carica "governa con i Tweet".
Circostanza che fa ormai parte del paesaggio politico, i
Tweet di Trump – una grandinata che ha inizio di buon mattino – hanno posto
sulle prime non pochi problemi "procedurali" a testate giornalistiche
abituate alle conferenze stampa effettuate in una cornice regolata. Che valore
attribuire a quei Tweet? Coprirli tutti avrebbe significato doversi occupare di
Trump per tutto il giorno? E che effetto avrebbe fatto alzarsi al mattino e
dover rincorrere i Tweet presidenziali della notte appena trascorsa?
Al pari della propaganda della Brexit, i Tweet di Trump
eludono il valore di verità delle asserzioni. Né il fatto che queste vengano
credute vere sembra l’obiettivo principale del parlante. Basta che esse
vengano credute da una parte – ovviamente, la più grande possibile – di chi
vede e ascolta.
Di passata, ricordiamo la categoria degli "alternative
facts" dell’addetto stampa Sean Spicer al momento dell’inaugurazione della
Presidenza Trump. La folla che assisteva era con tutta evidenza – foto e
filmati erano visibili da chiunque – di gran lunga meno numerosa di quella che
nelle medesime circostanze aveva accolto Obama. "Ma questi sono i vostri
fatti", aveva ribattuto Spicer, "e noi abbiamo i nostri. La nostra
folla è molto più grande." (Ci torneremo più avanti.)
In un mondo
policentrico, è ovvio che le fonti siano molteplici. Non tutte disinteressate,
ma questo è un problema con il quale l’individuo adulto ha imparato a fare i
conti tanto tempo fa.
La novità moderna è che il valore di verità attribuita varia
con il parlante, secondo criteri imperscrutabili.
E’ l’avverarsi del post-moderno come incubo, con la verità
che diventa una questione di "gusto".
Ma quello che era solo un bel gioco qualora riservato alle
aule universitarie e ai circoli intellettuali deflagra con prepotenza in un
mondo dove gli individui sono sottoposti a un bombardamento incessante di
informazioni delle quali capiscono poco o nulla mentre le più pazzesche teorie
della cospirazione vengono rilanciate sui "social".
Di fronte all’infinito, la mente vacilla. A ridurre il
sovraccarico, benvenute le più assurde teorie della cospirazione.
Agli albori della
Presidenza Trump, l’economista e premio Nobel Paul Krugman pregava che gli
Stati Uniti non si trovassero a essere investiti da una crisi finanziaria come
quella del 2008 o coinvolti in una guerra commerciale con la Cina. Questo perché
la cifra che contraddistingueva la nuova Amministrazione era con tutta evidenza
anti-scientifica (ne faceva fede l’atteggiamento negazionista nei confronti del
cambiamento climatico, atteggiamento che non sembrava attribuibile ai soli
interessi della potentissima "lobby del carbone"). Si sommava a ciò
la palese tendenza di Trump a circondarsi di "yes-man".
Ma quella vittoria veniva da lontano. Il rifiuto delle élite,
della specializzazione, della verità scientifica, il timore di essere
turlupinati dagli esperti, la presunzione di capire ogni cosa senza aver mai
dedicato al sapere il sudore necessario, la scomparsa dei "corpi
intermedi". Da cui l’aspirazione a vedere al governo "gente come
noi".
Accontentati!
Quello che nessuno avrebbe potuto prevedere è che a
cent’anni dalla Spagnola una nuova pandemia si sarebbe diffusa nel mondo
trovando pressoché dovunque al governo "l’élite de noantri",
ovviamente del tutto impreparata e antiscientifica fino al midollo.
E adesso?
La situazione per ciò
che riguarda "i giornali" o "la stampa" (termini con i
quali indichiamo anche quanto si trova in Rete: "giornali senza carta e
che nessuno ha mai stampato") è a ben vedere paradossale.
Da un lato, il comune sentire li vuole morti, ininfluenti,
retaggio del passato, aggregatori superati di un mix di notizie e servizi.
Ma la stragrande maggioranza delle notizie – e dei controlli
– viene ancora oggi dai giornali, che solo per un "combinato
disposto" di progresso tecnologico e mancato adeguamento legislativo
vedono Google e Facebook rastrellare da soli il 60% circa della pubblicità via
Internet, somma che in circostanze differenti sarebbe andata ad arricchire i
loro bilanci – e, si spera, le loro redazioni.
La conseguenza di tale depauperamento è che i giornali danno
meno, e di qualità più scadente, finendo quindi per perdere in autorevolezza. E
se a furia di tagli il giornale non riesce più a produrre notizie, la strada
obbligata è quella di produrre "commenti", che si fanno nella
comodità della propria casa. Da "i fatti separati dalle opinioni" a
"solo opinioni, e niente fatti".
Scendendo nella volgare quotidianità, è ben possibile che
parte della presente litigiosità interpretativa sui fatti e della
"Babele" che ci circonda sia il risultato ultimo di una povertà di
bilanci che consente il solo utilizzo di un terminale.
Se è lecito riandare
alla nostra esperienza passata, diremmo che al tempo della "copia letta al
bar" e dell’appuntamento fisso con il telegiornale – ambedue presentano
una "moltitudine ordinata" – il fruitore avesse un’idea del mondo.
Mentre oggi chiunque sa riferire aneddoti e fatti curiosi in quantità, ma se
interrogato dimostra spesso di non essere a conoscenza di fatti obiettivamente
importanti avvenuti nell’ambito della cronaca locale.
(Nella speciale condizione odierna, i fatti conosciuti sono
ovviamente molti di più. Ma in forma "grezza". Essi rimangono quindi
"incomprensibili".)
Ci sono poi coloro i quali leggono tanto e conoscono
moltissimo. Il punto dolente è che spesso questi lettori interpretano la parte
del "free rider", cogliendo fior da fiore senza mai scucire un soldo.
Da parte nostra formuliamo una raccomandazione: individuare
una testata sentita come congeniale e inondarla di soldi. (Gli esempi di cui si
discuterà più avanti dovrebbero rendere chiaro il perché di questa
raccomandazione.)
Nell’esperimento sociale che è la nostra vita, il
"giornale", pur se a tipologia variabile, è il prodotto migliore che
abbiamo quando si tratta di informazione. Un’entità "artificiale" che
è nostro interesse tenere in vita.
Per fare un esempio (ovviamente inventato), il magnate del
carbone potrà sempre finanziare emittenti televisive, giornali locali, ricerche
di scienziati che dicono che il cambiamento climatico quale opera dell’uomo è
una ipotesi ancora bel lontana dalla dimostrazione, un utilizzo improprio di
dati informatici atti a orientare il voto, e perfino un hackeraggio ostile
condotto da cento utenti che hanno base in Macedonia.
Il cittadino ha la sola possibilità di fare "massa
critica", un soldino ciascuno.
Giunti a questo punto,
sospettando fortemente di non aver convinto nessuno che non la pensasse già
come noi, per meglio comunicare il "panorama" abbiamo deciso di
presentare alcuni libri usciti in tempi recenti in modo da fornire un pool di
conoscenze facilmente comprensibili.
Abbiamo scelto tre libri:
l’autobiografia giornalistica di Alan Rusbridger, per
vent’anni direttore del Guardian, uscita nel 2018;
il resoconto in forma giornalistica del lavoro svolto da
David E. McGraw quale legale della redazione del New York Times, con
particolare attenzione al periodo della Presidenza Trump e al valore di verità,
uscito nel 2019;
uno svelto ma esaustivo libretto scritto da Margaret
Sullivan, ex "public editor" del New York Times e attuale "media
columnist" del Washington Post, uscito pochi mesi fa.
Fanno circa 850 pagine complessive. Le avevamo già lette al
tempo della loro prima pubblicazione, le abbiamo rilette la scorsa settimana.
Abbiamo accolto con grande
interesse la notizia della pubblicazione di un libro di Margaret Sullivan
dedicato alla progressiva scomparsa della stampa locale statunitense (e
ovviamente, come la stessa autrice non manca di sottolineare, di tutto il
mondo, comuni essendo le cause alla base di questa grande trasformazione).
Il lettore ricorderà forse il nome della Sullivan, da noi
più volte citato al tempo in cui la giornalista ricopriva – diremmo al meglio –
il ruolo di "public editor" del New York Times. Lasciata quella
carica, è oggi "media columnist" di un altro illustre quotidiano di
quel Paese, il Washington Post.
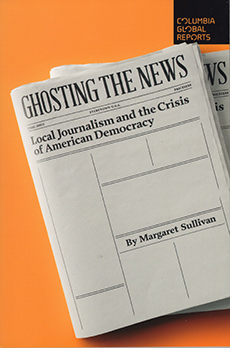
Ghosting The News – Local Journalism And The Crisis Of American Democracy (Columbia Global Reports 2020, $15.99, pp105) è uno snello libretto che fa parte di una collana che diremmo senz’altro "divulgativa", utile a farsi un’idea accurata di un problema con lo sforzo di solo poche ore di lettura.
La lunga carriera al Buffalo News – quotidiano nel quale entrò in qualità di "summer intern" e del quale scalò la gerarchia fino a diventarne direttore – consente all’autrice di cogliere con una sola occhiata quanto è andato perso durante quel tragitto e ancor più nel periodo successivo, quando il flusso del cambiamento ha subito un’enorme accelerazione.
Lo sforzo è quello di collegare la crisi del giornalismo locale (attributo che il lettore dovrà ricordarsi di dimensionare su una scala come quella statunitense) alle "disfunzioni" percepite: lo scemare dello spirito di comunità, l’aumento della corruzione conseguente alla scomparsa del "cane da guardia", lo "spostamento a destra" dell’elettorato rimasto con le Fox News quale unica fonte ("selettiva") di informazione. Il tutto mentre – sondaggi alla mano – i lettori sono in gran parte comvinti che la stampa locale goda di ottima salute.
I colpevoli sono noti: dalla scomparsa degli "annunci" ai giganti come Google e Facebook a drenare la pubblicità, dalla sostanziale apatia che caratterizza il lettore medio alla convinzione che, in qualche modo, le notizie ci saranno sempre.
I rimedi però latitano. La possibilità che la stampa venga sovvenzionata mediante aiuti pubblici – scenario che l’autrice introduce timorosa e con mille distinguo – ci ha fatto fare un salto sulla sedia: perché culturalmente poco "americano", e per gli effetti paradossi che il provvedimento potrebbe avere qualora la borsa finisse in mani "sbagliate".
Accanto, le solite speranze: sottoscrizioni, creazioni di pool di risorse – l’idea di un insieme di giornali che riceve assistenza legale da una fonte unica è interessante – comprensione del ruolo insostituibile che la stampa locale ha nella vita associata:
"After all, a newspaper’s purpose isn’t only to keep public officials accountable; it is also to be the village square for an entire metropolitan area, to help provide a common reality and touchstone, a sense of community and of place." (p34)
Tra i (pochi) libri segnalati nel volume di Margaret Sullivan quale ausilio per un eventuale approfondimento c’è quello di Alan Rusbridger del quale stiamo per dire. La cosa ci ha fatto piacere, ma non ci ha affatto stupito: Breaking News è un libro che ci sentiamo di definire fondamentale. Snello e comprensibile nonostante la mole (ma i caratteri di stampa – almeno quelli dell’edizione UK – sono di una certa grandezza) e la vastità della periodizzazione.
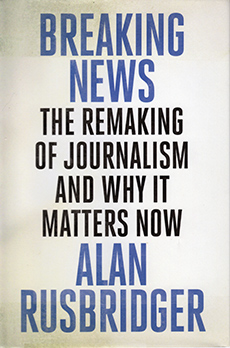
Breaking News – The Remaking Of Journalism And Why It Matters Now (Canongate 2018, £20, ppxxiv-440) è al contempo un libro di storia e una foto "instant" di un momento in cui tutto può accadere. E fortunatamente, almeno un po’ di quel "tutto" dipende da noi.
Il libro si sofferma giusto il necessario sugli inizi della carriera giornalistica di Rusbridger, per poi entrare nel vivo: il suo lavoro al quotidiano The Guardian e soprattutto i vent’anni in cui ne è stato il direttore.
E’ un tragitto che vede – ma è solo una distinzione analitica che facciamo in sede di recensione – il cammino parallelo di vicende storiche (lo scandalo delle intercettazioni e ricatti del News Of The World di Rupert Murdoch, il caso WikiLeaks, le rivelazioni di Edward Snowden, la Brexit, il recente scandalo che ha visto protagonisti Cambridge Analytica e Facebook) e di quelle innovazioni tecnologiche (Craigslist, Google, Facebook, Web 2.0) che tolgono ossigeno alle finanze di una testata mentre cerca di sopravvivere coltivando il difficile compito di esercitare un giornalismo onesto.
Va notato che il Guardian ha sposato la formula "aperta" che vede il rifiuto del "paywall" e un accesso libero. Una formula che prevede, e incoraggia, l’abbonamento, la sottoscrizione, l’offerta libera e tutte le formule di contribuzione intese a sostenere un quotidiano che interpreta il suo ruolo in un’accezione "oppositiva" (e il cui pubblico percepisce un reddito medio che lo rende decisamente poco appetibile agli inserzionisti).
Bibliografia, indice e note del volume sono ovviamente accuratissimi.
Tra tanta abbondanza, difficile enucleare episodi singoli.
Quello che di solito ci viene in mente per primo riguarda lo scandalo delle intercettazioni effettuate clandestinamente dal quotidiano News Of The World (il lettore italiano ricorderà senz’altro la fluente chioma di Rebekah Brooks e il coinvolgimento di nomi quali Hugh Grant e Sienna Miller). Ma la vicenda aveva anche gravi implicazioni politiche, una patata bollente che il resto della stampa si guardò bene dal prendere in mano e che lasciò il Guardian nella scomodissima posizione di essere visto come chi ha ingigantito una vicenda tutto sommato minuscola.
Entra la cavalleria, nella persona di Bill Keller, direttore del New York Times.
"I rang Bill Keller (…) and explained how we could not run the full Rees story; and also, how much of the British press was steadfastly ignoring the saga. Keller put three reporters on a plane that week. They stayed in London for the best part of six months. (…) The NYT published a 6,000-word account of the phone hacking saga at the beginning of September 2010. It had taken an American newspaper to do what any British news outlet (or police or regulator or politician) had been free to do: to investigate an incredibly important and compelling story and find out whether the Guardian was right or wrong." (p189)
Un filo che corre sottotraccia per tutto il volume è la stretta collaborazione intercorsa con testate statunitensi allorquando il gioco si fa planetario e i rischi enormi: il New York Times, come s’è detto, e il Washington Post. Non è solo una questione di "suddivisione rischi" (ma ci sono pagine con file che sorvolano l’Atlantico e copie di dischetti che vengono distrutti sotto sguardi attenti e minacciosi degne di una spy-story – solo che è tutto vero!) ma di una diversa cornice legale, con il famoso "Primo Emendamento" a ricorrere più volte.
Abbiamo fatto un nodo al fazzoletto per non correre il rischio di dimenticare due nomi: Sarah Boseley e Ben Goldacre. La prima ha propiziato un’accuratezza poco comune nel campo delle notizie medico-scientifiche – accuratezza e precisione che, già preziosi in tempi comuni nell’arginare l’oscurantismo e gli interessi dei mercanti di "wellness", si rivelano decisivi nei giorni drammatici che stiamo vivendo. Il secondo, eccellente "battitore libero" poi autore di alcuni libri di buon successo, ha costituito una eccellente cerniera tra il disvelamento degli interessi di "Big Pharma" e la ferma difesa della razionalità, con deciso respingimento delle opinioni "negazioniste". Di Goldacre ricordiamo anche la rubrica, Bad Science, nella quale provava l’erroneità scientifica e statistica di quanto contrabbandato come vero da medici, politici, aziende, giornalisti e figure assortite.
Anche se scegliere fra questi libri sarebbe un compito impossibile – troppo diversi per scopi e ambizioni, risultano alla fine tutti ugualmente indispensabili, e a ben vedere complementari – dobbiamo confessare di nutrire una predilezione particolare per il volume che abbiamo lasciato per ultimo.

Truth In Our Times – Inside The Fight For Press Freedom In The Age of Alternative Facts (All Points Books 2019, $28.99, ppxi-288) è una lunga meditazione sulle possibilità di sopravvivenza della Verità resocontata con millimetrica precisione da David E. McGraw, "Deputy General Counsel Of The New York Times". Ovvero l’avvocato il cui compito è affiancare e consigliare la redazione del giornale in tutti gli aspetti legali del lavoro giornalistico come prodotto.
Dire che il libro è di lettura facile e scorrevole sarebbe un incoraggiamento decisamente poco onesto. Sono 300 pagine di quelle toste, scritte con caratteri piuttosto minuti e non molto distanziati. L’approccio è divulgativo, ma il linguaggio è estremamente preciso e a basso tasso di ridondanza. Insomma, McGraw incarna alla perfezione – e con estrema naturalezza – la figura dell’avvocato onesto che sta dalla nostra parte resa celebre da tanti film di Hollywood.
Passano in rassegna scandali grandi e piccoli, con WikiLeaks, Assange, Snowden, la CIA, la NSA, e Weinstein nel ruolo di protagonisti.
Ma la narrazione si fa nervosa man mano che prende corpo lo sfondo politico e sociale su cui si stagliano l’elezione e la condotta presidenziale di Donald Trump. Lo "strappo" viene quindi ricondotto nella cornice legale propria alla dimensione professionale dell’autore, che giunge a interrogarsi sul destino di un Paese che sembra aver rinunciato a una nozione di Verità che si riveli "super partes".
Leggiamo dall’introduzione:
"I have spent a decade and a half as the newsroom lawyer for The New York Times. I set out with a modest objective for this book: to let readers look behind the scenes at some of the most consequential reporting done by The New York Times and to understand how, sometimes quietly and sometimes not, the law protected journalism, shaped it, and, in a more fundamental way, made it possible. (…) America’s tradition of press freedom will not survive if the First Amendment strikes people as abstract and disconnected from the real life of the country or nothing more than a vehicle for advancing some political agenda. In journalism, the First Amendment happens at ground level, empowering and illuminating choices that journalists make every day in their pursuit of the truth. That is the story told in these pages." (ppix-x)
Il capitolo che ogni volta ci sorprende e cattura di più è il sesto, intitolato Us vs Us. Una lunga riflessione sull’obbiettività che ritorna ai giorni della supposta "false equivalency" del quotidiano, accusato da molti lettori di avere ingigantito le colpe attribuite alla candidata del Partito Democratico Hillary Clinton – che essi ritenevano veniali – allo scopo di controbilanciare le accuse rivolte al candidato repubblicano Donald Trump (è ovviamente il 2016).
Il fatto senz’altro più peculiare narrato nel libro prende il via da un Tweet di Trump presidente – sono le 7:23 p.m. del 24 luglio 2017. "The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad…"
Il programma della CIA al quale il Tweet faceva riferimento era classificato come "national security secret". La stessa classificazione spettava alla decisione di Trump di abolirlo. Con un Tweet, il Presidente aveva rivelato a milioni di persone l’esistenza – e la cancellazione – di un segreto di massima sicurezza.
Ma era possibile cancellare un programma di quel tipo tramite un Tweet? E adesso che tutto il mondo ne era a conoscenza, era possibile ottenere le carte che riguardavano il programma?
Seguiva una disputa logico-grammaticale sulla sintassi del Presidente. Se il programma era inesistente, se era stato "fabricated" dal Washington Post come sostenevano gli avvocati della CIA come poteva essere allo stesso tempo "massive, dangerous and wasteful" e "nonexistent"?
Su un piano decisamente meno surreale, l’episodio dell’invio da parte della NSA di documenti richiesti dal giornale e riguardanti le operazioni di raccolta dati concernenti le telefonate effettuate da cittadini statunitensi. Protagonista dell’operazione la stessa NSA. Sorpresa!, il giornalista destinatario riceve erroneamente anche dei documenti "classified" che la NSA vuole immediatamente indietro. Ma ha il diritto di farlo?
I commenti dell’addetto stampa Sean Spicer a proposito della grandezza della folla presente all’inaugurazione (pp25-26), e l’invenzione degli "alternative facts" poi ribadita dalla "Trump aid" Kellyanne Conway a Chuck Todd della NBC (Todd: "Look, alternative facts are not facts. They’re falsehoods." pp166-167) ci gettano in un’atmosfera da incubo in cui la speranza di poter intavolare un dialogo viene sommersa da un mare di Tweet.
Il lavoro della stampa è protetto dalla legge. Ma quante chance di incidere sulla realtà ha il lavoro rispondente a carattere di verità se il pubblico accomuna la gran parte dei media nel calderone maleodorante delle "fake news"?
In un modo o nell’altro, è una domanda destinata a ricevere una risposta molto presto.
© Beppe Colli 2020
CloudsandClocks.net | Oct. 29, 2020


